Insipienza o complotto ?
Le vicende che abbiamo raccontato nei capitoli precedenti sono generalmente poco note, tanto e’ vero che molti pensano che il personal computer sia stato inventato in America nei primi anni 70, ossia sette anni dopo la realizzazione della Programma 101. La stessa Olivetti non ha mai dato particolare enfasi a quell’evento, forse perché associato ad un periodo molto tribolato della sua storia. Eppure io sono convinto che la storia dell’informatica italiana degli anni 60 sia estremamente ricca di insegnamenti, sia per la fase che la nostra economia e la economia mondiale stanno attraversando ora ( 1993 ), sia per una più approfondita valutazione dei fenomeni che caratterizzarono, dopo la seconda guerra mondiale, il miracolo economico italiano e la sua fine.

Allora come oggi assistiamo alla fine di un periodo di tumultuoso sviluppo, dopo il quale ci troviamo con l’economia stagnante, le aziende fortemente indebitate e in crisi, gravi preoccupazioni per la occupazione. Ma sopratutto sembra che i due momenti siano caratterizzati da una netta discontinuità col passato, e che lo sviluppo tumultuoso ma continuo venga ad un certo punto sostituito da un salto, nel quale tutte le carte vengono rimescolate e nuovi modelli, nuovi paradigmi, nuovi valori, vengano improvvisamente alla luce.
In un bel libro, molto documentato, scritto dal giornalista Lorenzo Soria, intitolato ” Informatica: un’ occasione perduta ” [4] , si ventila il sospetto che nei primi anni 60, tre eventi traumatici, la morte di Enrico Mattei a Bascape’ nell’ottobre del 62, il caso di Felice Ippolito ( con la demolizione della ricerca nucleare in Italia ) verificatosi un anno dopo e la cessione agli americani della Divisione elettronica dell’Olivetti nell’agosto del 1964, siano legati da un unico sotterraneo filo conduttore. Quello di un complotto internazionale, finalizzato a relegare l’Italia in un ruolo subalterno nella divisione internazionale del lavoro, neutralizzando i tentativi di occupare una posizione più avanzata in tre settori fondamentali per lo sviluppo, i nuovi materiali, l’energia e l’informazione.
Ma più che ad un complotto ordito da qualche misterioso grande vecchio, in rappresentanza del grande capitale internazionale, le cause della caduta dei sogni dei primi anni 60 vanno ricercate nella arretratezza culturale di un mondo industriale che aveva sempre trovato più comodo percorrere vie di sviluppo molto tradizionali e che l’innovazione aveva sempre preferito importarla piuttosto che crearla. Un mondo per il quale la ricerca e la sperimentazione di vie nuove non erano legittimate, erano considerate spreco di risorse, megalomania, mancanza di concretezza. E’ significativa a questo riguardo la dichiarazione di Valletta, fatta all’assemblea della Fiat del 30 aprile del 1964, con riferimento alla ipotesi di intervento nel capitale Olivetti: ” la società di Ivrea e’ strutturalmente solida e potrà superare senza grosse difficoltà il momento critico. Sul suo futuro pende però una minaccia, un neo da estirpare: l’essersi inserita nel settore elettronico, per il quale occorrono investimenti che nessuna azienda italiana può affrontare “.

Ma questa arretratezza culturale dove esattamente risiedeva ? Era un fenomeno diffuso e generalizzato, quasi come un inprinting genetico, oppure caratterizzava solamente un establishment che monopolizzava il potere e le strutture di governo dei grandi gruppi industriali del nostro paese ? Guarda caso, quasi lo stesso interrogativo e’ da porsi oggi, con riferimento alla crisi attuale, con la differenza che essa oggi investe anche il mondo politico e che la consapevolezza della necessità urgente di un cambiamento generalizzato e’ ora assolutamente esplicita. Ma se, col senno di poi, nel 1993 capiamo in quale direzione avremmo dovuto andare negli anni 60 e quali occasioni abbiamo allora perduto, l’interrogativo sulla direzione nella quale oggi dobbiamo andare diventa cruciale. Anche per questo la storia dell’elettronica Olivetti può insegnare qualcosa.
Tra contafagioli e contapiedi.
La storia Olivetti degli anni 60 dopo la morte di Adriano e quella di tante altre aziende dimostra che si può arrivare al vertice di una organizzazione e stare sul ponte di comando, senza capire nulla di quello che nel profondo della stiva sta avvenendo e senza avere la minima consapevolezza dei segnali premonitori di possibili grandi mutamenti. Abbiamo una infinità di esempi e possiamo farli, sia nei settori nei quali la Olivetti operava, sia in molti altri campi, prossimi e lontani. Quasi nessuna delle aziende che producevano calcolatrici e macchine per scrivere meccaniche, tedesche e americane. e’ ancora viva oggi: nessuno ricorda nemmeno più i nomi di aziende come Monroe, Friden, Victor, Triumph-Adler e tante altre. Nessuna delle aziende che negli anni 50 producevano tubi elettronici e’ riuscita a convertirsi e a diventare competitiva nel campo dei componenti sostitutivi, i semiconduttori.
Venendo ad anni più vicini a noi osserviamo che tutte le aziende americane che operavano nel campo dell’elettronica civile, TV, Hi-Fi, videoregistratori, sono state cancellate e l’industria quasi al completo e’ migrata sotto le bandiere giapponesi.
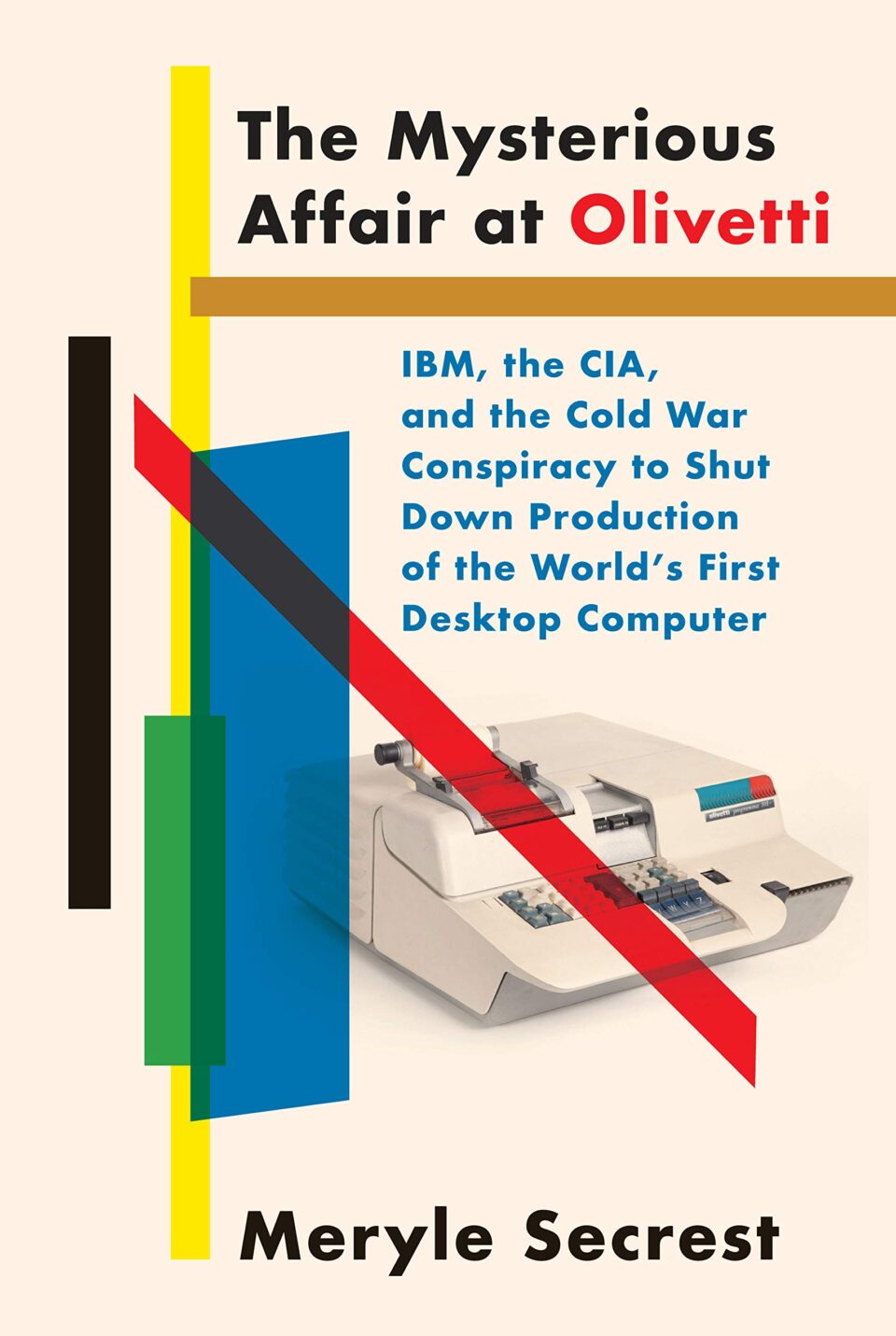
Le aziende che si stanno affermando nel campo delle biotecnologie non sono i grandi colossi della chimica, ma aziende nascenti o neonate, fondate, nella più parte dei casi, da tecnici o scienziati che hanno saputo trasformarsi in imprenditori.
In moltissimi casi le aziende nei cui laboratori di ricerca sono state fatte le scoperte più interessanti, non hanno saputo sfruttarle e trasformarle in prodotti. Si può ancora citare a questo proposito l’esempio dei semiconduttori, scoperti negli anni 40 nei grandi laboratori della Bell americana, che furono poi sfruttati dalle aziende nate nella famosa Silicon Valley californiana.
I grandi manager le cui gesta, a base di acquisizioni, joint venture, colpi di mano, vengono di solito raccontate con grida di ammirazione dalla stampa, nella più gran parte dei casi hanno finito col portare alla rovina le loro aziende e se stessi.
Allora c’e’ da chiedersi: tutti i complessi apparati a base di contafagioli ( leggi: strateghi, amministrativi, contabili, esperti finanziari, ecc. ), e di contapiedi ( leggi: gestori delle risorse umane, capi del personale, ecc. ), che costituivano una fetta rilevante delle strutture e dei costi aziendali, che strumenti hanno usato per supportare le così infelici decisioni dei loro capi ? Possiamo ancora fidarci di loro per costruire il futuro delle aziende nei momenti di grande discontinuità, oppure la loro funzione e’ utile soltanto quando il futuro non e’ altro che la continuazione del passato ? Purtroppo questo lo si sa solo dopo, e di solito e’ troppo tardi.
Il caso Olivetti della cessione della Divisione elettronica proprio alla vigilia della rivoluzione microelettronica sta’ quindi in buona compagnia ed e’ ben lungi dall’essere isolato. Anche in Olivetti esistevano nutrite legioni di contafagioli e contapiedi, che non hanno dato alcun contributo alla creazione della Divisione elettronica, certamente iniziativa personale di Adriano, e hanno invece appoggiato con calore l’infausta cessione. Anche nel dopo-Peccei queste stesse persone hanno sempre ostacolato e opposto muri di gomma al processo di trasformazione dell’azienda. perché era insito nella loro cultura e nel modo con cui tradizionalmente hanno sempre interpretato il loro ruolo, ostacolare o rallentare ogni cambiamento.
Eppure in quasi tutte le aziende esistevano ed esistono altre risorse umane, talvolta nascoste o misconosciute, che non vengono per nulla valorizzate, anzi, in molti casi, vengono considerate estremamente pericolose nella misura in cui danno segno di voler esprimere qualche tipo di creatività!
Se andiamo a vedere, una certa parte dei capi di azienda nel mondo, ma sopratutto in Italia, apparteneva e appartiene tuttora alla categoria dei contafagioli e contapiedi, i quali non sono tali per titolo di studio o patrimonio genetico, ma per cultura.
I contafagioli erano portatori di una cultura contabile quantitativa, che vedeva il mondo deformato e reso unidimensionale attraverso la apparente e mistificatoria univocità dei numeri.
I contapiedi vedevano il mondo aziendale sotto la dimensione totalizzante del rapporto gerarchico verticale, ma con netta prevalenza della direzione top-down, e il loro unico interesse era una visione arcaica, vetero-industriale, del potere, del quale si sentivano essere la cinghia di trasmissione verso l’azienda. Essi non sapevano far di conto, ma si limitavano ad utilizzare due operazioni, l’addizione in periodi di boom e la sottrazione in periodi di crisi.
Per entrambe le categorie, i confini dell’universo erano il perimetro aziendale e il resto del mondo non esisteva.
E’ significativo riportare un particolare che riguardava il lessico aziendale dell’Olivetti, ma che e’ illuminante di una mentalità. Nei prospetti che venivano continuamente elaborati dai contafagioli e contapiedi ancora negli anni 70 sul personale , gli operai venivano chiamati col loro nome, ovvero ” diretti produttivi ” e tutti gli altri, ossia la grande maggioranza di tecnici, specialisti, ricercatori, esperti di organizzazione, ecc. venivano sbrigativamente riassunti sotto l’epiteto di “altre categorie “! Ancora nella seconda metà del ventesimo secolo dominava quindi l’idea dell’azienda ottocentesca, fatta di operai che producono da una parte e di ausiliari, servi del padrone, dall’altra.
Adriano Olivetti aveva cercato di allargare i confini culturali dell’azienda aprendola verso interessi più vasti, tra i quali dominanti erano una urbanistica del territorio, una visione sociale ed una ricerca di valori estetici, assolutamente innovativi nel mondo dell’industria italiano, ma, a livello delle persone, questa integrazione non era avvenuta. Gli intellettuali erano rimasti al di fuori del circuito aziendale, separati e giustapposti al mondo della fabbrica. E quando hanno assunto ruoli di responsabilità operativa, sopratutto nel campo del personale o delle relazioni esterne, non hanno mai saputo farsi interpreti dei segnali che questa produceva e meno che mai sono stati capaci di integrare cultura tecnica e cultura umanistica.

Dagli stessi scritti di molti letterati che lavorarono in Olivetti fin dagli anni di Adriano, come ad esempio Paolo Volponi, che fu capo del personale negli anni della grande mutazione aziendale verso la elettronica e l’informatica, mai si coglie il minimo segno che essi vedessero l’azienda come elaboratrice di un nuovo rivoluzionario scenario: per essi la fabbrica era sempre e solo il luogo della lotta del potere e dello scontro tra capitale e lavoro.
Questa sensazione e’ chiarissima, ad esempio nel libro ” Le mosche del capitale” di Volponi, nel quale viene descritta una Olivetti immaginaria presieduta da un personaggio, denominato Nasapeti, che assomiglia più ad un ottocentesco cinico padrone delle ferriere, che non al cauto presidente, che, nella realtà, galleggiava ignaro su un’azienda in vorticosa trasformazione.
Negli anni 60, esattamente come negli anni 90, sembra che la semplice idea dell’impresa il cui fine non e’ il solo profitto, ma la costruzione di un nuovo scenario e di una nuova architettura di prodotti materiali e immateriali, destinati a migliorare il mondo e non solo a sfruttarlo e a possederlo, stenti ad entrare nella testa dei grandi imprenditori e a diventare la base di una rinnovata cultura d’impresa.
Spazio alla creatività.
La realizzazione della Programma 101 della Olivetti divenne uno dei “casi ” sviluppati dall’università’ di Harvard ai fini di studio e di formazione del management aziendale. La morale del caso era più o meno quella di un’occasione perduta, buttata via. Il caso, sempre più raro oggi, di una azienda che, per almeno cinque anni, viene a disporre di un prodotto rivoluzionario praticamente senza concorrenza alcuna, e non riesce a capitalizzare e sfruttare stategicamente una simile situazione non poteva non diventare da manuale.
Ma fu veramente un insuccesso ? Dal punto di vista del prodotto, certamente no. Ne furono prodotte negli anni circa 44.000 nelle varie versioni e la sua redditività fu altissima, malgrado che la burocratica prassi aziendale di allora in fatto di conti non consentisse di fare una valutazione a consuntivo, cosa della quale peraltro nessuno si preoccupò. In un certo senso il grande successo del prodotto mise in evidenza l’inadeguatezza dell’azienda e della sua organizzazione, in quanto esso rimase almeno fino al 1967-68, cioè per quasi tre anni, un elemento isolato.
La macchina sembrava agli occhi di qualunque osservatore esterno la prima espressione di una nuova strategia, di una nuova visione del mondo, nella quale la Olivetti si presentava come campione della nascente informatica distribuita contro il Golia IBM, difensore della informatica centralizzata. Però questa strategia mancava, o era solo nella mente dei pochi sparuti progettisti.
Viene spontaneo fare un paragone tra la strategia IBM, che nel 1981 introdusse sul mercato il suo personal computer, anch’essa in netta contraddizione con tutta la sua tradizione aziendale e il caso Olivetti del 1965. L’IBM dovette scendere dalle vette della grande informatica, mentre la Olivetti dovette risalire dalle valli del calcolo meccanico.
Ma anche la IBM, nel gestire questa discontinuità, pure per lei traumatica, fece un errore di strategia. Per la prima volta un’azienda, che aveva sempre autoprodotto tutti i componenti dei suoi prodotti, si limitò a fare un assemblaggio, comprando il microprocessore dalla Intel, il software di base dalla Microsoft, altri moduli da altri produttori esterni. Anch’essa, come la Olivetti, per superare i vincoli di una cultura aziendale ostile, dovette far nascere il personal in una divisione separata ed autonoma rispetto al corpo grosso dell’azienda ( ricordate la Divisione sistemi di Roberto Olivetti
Ma questi non furono tanto errori ma necessità.
L’errore dell’IBM invece fu di non essersi preoccupata di tenere saldamente nelle mani le chiavi della architettura del mondo dei personal computer, anche se inizialmente riuscì a conquistare una fetta di mercato maggioritaria. Il dominio di tale architettura passò nelle mani dell’ Intel ( ricordate l’Intel fondata da Bob Noyce, l’inventore dei circuiti integrati di cui parlammo nel quinto capitolo ? ) e della Microsoft, che riuscirono a controllare e a determinare l’evoluzione rapidissima di questo agitato mondo, diventando i leader e i gestori dei componenti fondamentali dei prodotti, microprocessore e software. La conseguenza e’ che queste due aziende ottengono risultati economici spettacolosi mentre l’IBM ha cominciato a perdere soldi e sembra aver imboccato un cammino discendente assai preoccupante.
Anche in Olivetti il guaio fu che, dopo l’exploit della Programma 101, non si riuscì a ” controllare ” lo sviluppo delle architetture nel campo dell’informatica distribuita. Si sarebbe dovuto, dopo il primo prodotto, far uscire con grande rapidità nuove versioni aggiornate e allargare subito la gamma dei prodotti, in modo da occupare tutti gli spazi, dettando gli standard di fatto del nuovo immenso mercato che si apriva. Ma le risorse mancavano e si dette tutto il tempo ai concorrenti di occuparlo.

Decisamente, la cultura delle grandi aziende non sembra trovarsi a proprio agio, quando si tratta di navigare in mezzo a grandi discontinuità ! Ma la spiegazione esiste ed e’ forse più semplice di quanto non si possa immaginare. Le discontinuità, le grandi improvvise mutazioni, non sono fenomeni metereologici, ma vengono promosse e realizzate da persone e da aziende; e molte di esse nascono con il prodotto e con l’idea del loro fondatore. E questi non devono vedersela con sciami di contafagioli e contapiedi, ma semplicemente con le difficoltà vere del mondo esterno, che si pone automaticamente al centro delle loro attenzioni. Il mondo esterno non e’ quindi un lontano orizzonte intravisto al di là delle schiene dei capi e dei capi dei capi, ma il luogo vero dove si misura il successo o l’insuccesso dell’idea. Certo, la mortalità di queste iniziative e’ elevata, perché anche oggi una buona parte degli inventori muoiono poveri, però esse costituiscono il sale di ogni processo innovativo, a livello di aziende e di sistema-paese.
Ma le grandi aziende sono forse condannate a non riuscire più a generare innovazione e ad assistere al rinnovarsi dell’epopea del ” piccolo e’ bello ” ? Non credo. Non e’ solo una questione di dimensioni, il piccolo, il creativo, l’innovativo, possono benissimo vivere e svilupparsi anche nel corpo di un grande organismo, attraverso un intelligente assetto organizzativo, che favorisca l’integrazione più che una quasi corporativistica specializzazione e che consenta la costruzione di competenze e mansioni più ” rotonde “.
Si tratta di una filosofia organizzativa detta ” olistica ” ( dal greco öos , il tutto ), nella quale in ogni singola unità organizzativa sono presenti ed integrate l’universo delle competenze e degli interessi aziendali. Ed e’ un tipo di organizzazione che Adriano aveva anticipato già dagli anni 50 e che aveva dato risultati positivi a livello di gruppi di progettisti. Certamente la gestione di queste strutture richiede la mano illuminata del Principe e non può essere fatta in un’ottica di occhiuta burocrazia tradizionale. Però diventa essenziale in una azienda che si ponga sul mercato con la volontà di essere innovativa e sappia adottare una logica di razionalizzazione del suo spazio esterno, di tipo sistemico, e concepire scenari innovativi.
